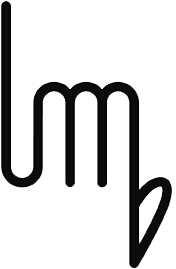Strumentazione: tenore solo, coro e orchestra sinfonica
Dedica: Laurence Traiger
Prima esecuzione | Interpreti:
Esecuzioni successive:
Edizione: opera inedita
Descrizione: Cantata sinfonica sul testo liturgico del canto di Simeone “Nunc dimittis” (Luca 2,29-32). Il brano è dedicato al mio insegnante di composizione Prof. Laurence Traiger ed è stato commissionato dal MaxChor di Monaco di Baviera per un grande concerto sinfonico di beneficenza nella Herkulessaal di Monaco di Baviera.
BREVE INTRODUZIONE DEL COMPOSITORE ALLA CANTATA “THE SONG OF SIMEON” Op. 41
Sono particolarmente grato al MaxChor e al suo direttore Gerald Häußler per avermi commissionato un brano da eseguire in occasione di questo concerto di beneficenza.
Uno dei motivi principali di questa gratitudine è anche il fatto che mi hanno lasciato completa libertà nella scelta del testo e della forma della composizione; l’unica restrizione era la durata, che non doveva superare i dieci minuti circa.
Partendo da questi presupposti, ho pensato subito a una breve cantata per voce solista, coro e orchestra. Ma il testo da utilizzare rimaneva aperto e sconosciuto, poiché non solo doveva essere conciso per rispettare la durata prescritta, ma anche in armonia con lo scopo benefico del concerto. E trovare un testo del genere non sarebbe stato certamente facile. Ma come spesso accade in questi casi, in cui si cercano per giorni e settimane il testo ideale, tutto si è risolto in un attimo quando ho preso in mano un libretto con i testi della Liturgia delle Ore, in cui era contenuto il testo che ho utilizzato per “The song of Simeon”.
Il Nunc dimittis, noto anche come “Cantico di Simeone”, è uno dei testi più sublimi e commoventi delle Sacre Scritture. Originariamente riportato nel Vangelo di Luca (Lc 2,29-32), descrive il momento in cui il vecchio Simeone vede il bambino Gesù nel tempio di Gerusalemme e capisce che lo scopo della sua vita è ormai compiuto. Ora può andarsene in pace: un messaggio caratterizzato da profonda gratitudine, sacra serenità e certezza della promessa divina.
Questo inno riassume un tema esistenziale: il desiderio di appagamento, la ricerca di conforto e il distacco definitivo da tutto ciò che è terreno. Il vecchio Simeone aveva dedicato la sua vita all’attesa: l’attesa della salvezza di Israele, della rivelazione di Dio, dell’arrivo di colui che avrebbe portato la luce nell’oscurità. Ora che ha visto il bambino divino, capisce che i suoi occhi hanno visto la salvezza, che il Messia è arrivato e che lo scopo della sua vita è stato raggiunto.
Il simbolismo è profondamente radicato: Simeone non parla solo per sé stesso, ma per l’intera umanità che desidera la salvezza. Gesù appare come luce per i pagani e gloria di Israele. A questo si collega il tema dell’attesa universale della salvezza con il suo concreto compimento in Cristo: un momento in cui profezia e realtà confluiscono.
Nel corso della storia della musica, diversi compositori hanno composto brani su questo testo, soprattutto molti della tradizione anglosassone, dove il canto riveste un ruolo particolare nella liturgia anglicana. Tuttavia, sono pochissimi i brani dedicati al “Nunc dimittis” che utilizzano un’orchestra così potente come quella che posso utilizzare per la mia versione che, secondo le mie prime ricerche, è forse la prima in questa forma e con questa formazione nella storia della musica.
Questa cantata è la mia prima opera così ampia che ho intrapreso dopo l’interruzione forzata del corso privato di composizione che avevo iniziato alcuni anni fa con il Prof. Traiger. Il Prof. Laurence Traiger è deceduto improvvisamente nell’ottobre dello scorso anno.
La cantata inizia con un arioso per tenore solista. Secondo le regole della tradizione musicale, i personaggi biblici di una certa età, come nel caso di Simeone, sono rappresentati da voci gravi. Tuttavia, per la mia cantata ho scelto un tenore. Una voce tenorile, soprattutto nella tradizione operistica, è solitamente associata a un personaggio giovane, gioioso e pieno di speranza, proprio come il canto di Simeone è pieno di vita e di speranza.
In questo primo arioso e nelle sue prime battute, il celesta entra con una scala di otto note. Il numero otto è considerato nella tradizione teologica cristiana come simbolo di nuovo inizio, resurrezione e nuova vita in Cristo. I primi padri della Chiesa consideravano la domenica come l’“ottavo giorno”. Anche nella tradizione ebraica il numero otto simboleggia un nuovo inizio. Secondo la Kabbalah nello Zohar, il numero otto sta per questo perché l’ottavo giorno era il primo giorno dopo la creazione in cui Dio tornò al lavoro: la settimana ricominciava da capo. Inoltre, nella tradizione ebraica, la circoncisione avviene di solito l’ottavo giorno dopo la nascita.
Segue una breve aria, anch’essa per tenore solista, dal carattere molto romantico. Il bellissimo testo mi ha ispirato a scrivere nello stile del belcanto italiano.
Segue un coro dedicato a Ravel (di cui quest’anno celebriamo il 150° anniversario della nascita), in cui la melodia eseguita dal tenore viene ripresa prima singolarmente, poi in canone dalle voci maschili e femminili del coro, su uno sfondo orchestrale ispirato ritmicamente alla composizione più famosa del compositore francese, che sicuramente tutti riconosceranno. In questo caso, però, la dinamica è invertita e il movimento si conclude con il coro e l’orchestra che lentamente si spengono. Il testo parla del popolo d’Israele e l’ho immaginato come una grande carovana canora che mi passa davanti e poi scompare in lontananza nel deserto. Con questo coro si conclude il testo pronunciato da Simeone nel Vangelo di Luca.
Ma seguendo l’antica tradizione della preghiera cristiana, che conclude un salmo o un inno di lode con il “Gloria Patri”, la breve dossologia che affonda le sue radici nel IV secolo d.C., anch’io ho voluto utilizzare questo bellissimo testo per concludere la mia cantata. Al maestoso “Gloria Patri” segue il “Sicut erat”, strutturato sotto forma di fuga, in cui ho utilizzato il tema di una fuga dalla mia suite per violino e viola: proprio questa fuga è stata oggetto della mia ultima lezione di composizione con il mio insegnante di composizione, il Prof. Traiger.
Questa cantata è dedicata a lui.
Lucio Mosè Benaglia
www.luciomosebenaglia.com
Monaco di Baviera, 28.11.2025
Concerto di beneficenza a favore del Caritas Baby Hospital di Betlemme